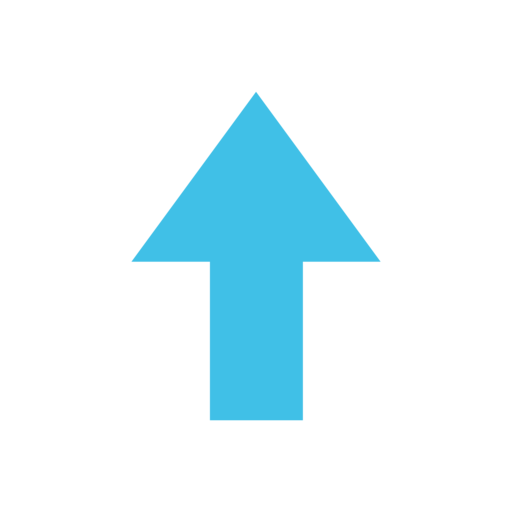“Eredità culturale immateriale e identità di Lambrate, gli anni del cambiamento”
I SEGNI DELLA MEMORIA
Le stazioni e la ferrovia
Lambrate e Ortica sono legati alla ferrovia, che ne definisce i confini.
Una frase ancora in uso, “Oltre il ponte”, sottolinea la separatezza tra questo territorio e “la città”.
Lo scalo ferroviario, lo smistamento, la rete dei binari che entravano anche nelle fabbriche (Innocenti e Mulino Bianchetti) hanno poi rappresentato per decenni elementi attrattivi per gli insediamenti produttivi in questo territorio.
Quando la Stazione Centrale si trovava nell’attuale piazza della Repubblica, la disposizione dei binari era ovviamente diversa da quella attuale: il tracciato dei binari, sui terrapieni, percorreva l’attuale viale Tunisia, passava sopra Corso Buenos Ayres, poi viale Regina Giovanna, viale Giustiniano e arrivato alla cascina Acquabella (piazzale Susa) si univa col ramo sud delle ferrovie e verso viale Argonne e quindi l’Ortica.
Nella piazza del Santuario venne realizzata nel 1896 la prima stazione, oggi ancora visibile. La stazione fu dismessa nel 1931, dopo la completa ristrutturazione della rete ferroviaria milanese. Nel 1935 venne attivato, all’interno della struttura, il dopolavoro ferroviario con campi di bocce e una balera frequentatissima che venne chiusa solo una decina di anni fa, per riaprire con il nome di “Balera dell’Ortica”.
Ortica, che fino al 1923 faceva parte del Comune di Lambrate, prende il nome da “orto” e “ortaglia”, dalle attività agricole che si svolgevano nei campi e nelle cascine di Cavriano.
Già a metà dell’Ottocento il borgo fu diviso dalla strada ferrata che andava a Treviglio, e da snodi, magazzini e depositi connessi alle ferrovie.
Per averne una idea, si può visitare il deposito Locomotiva di Milano Smistamento, in via Corelli, che nasce per far fronte all’esigenza delle Ferrovie dello Stato di avere un grosso Scalo Merci alle porte di Milano. Agli inizi degli anni ’30 la nuova Stazione Centrale di Milano è operativa e con essa anche il Deposito e lo Scalo di Milano Smistamento, sorti in posizione strategica a nord-est della città, tra le Stazioni di Lambrate e Pioltello, sulla Milano-Venezia. Ancora in funzione per alcune attività di manutenzione, oggi è sede anche della «Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento». E fra il 2000 e il 2003 dai capannoni dell’Officina Media di Milano Smistamento esce il maggior numero di rotabili ridipinti dai Pittori di Smistamento, nome con il quale il gruppo ormai era conosciuto in tutta Italia: in tre anni si contano circa una dozzina di locomotive ricolorate, buona parte delle quali appartenenti al gruppo E.645,  che in quegli anni era interamente assegnato a Milano Smistamento.
che in quegli anni era interamente assegnato a Milano Smistamento.
Il borgo di Ortica era anche caratterizzato dalla presenza delle case dei ferrovieri, su via Cima, in via Amadeo e in via Rosso di San Secondo. Nonostante i molti cambiamenti, ancora oggi il quartiere storico di Ortica è un’enclave chiusa dai binari con solo tre accessi automobilistici.
Il primo fabbricato della stazione di Lambrate si affaccia su Piazza Bottini, e fu costruito nel 1914 insieme al sistema di binari collegati alla nuova Stazione Centrale. Fu aperta al servizio passeggeri nel 1931, con la riorganizzazione dell'intero nodo ferroviario milanese.
Negli anni novanta fu costruito il nuovo fabbricato viaggiatori, progettato dall'architetto Ignazio Gardella. Gardella, genovese di origine, si laureò in ingegneria al Politecnico di Milano nel 1928, mentre ottenne successivamente la laurea in architettura allo IUAV, Istituto Universitario d'Architettura di Venezia, nel 1949. Nel periodo universitario entrò in contatto con gli altri giovani protagonisti della scena milanese assieme ai quali prese parte attiva alla creazione del Movimento Moderno italiano. La figura di Gardella rimase ai vertici dell'architettura italiana per tutti gli anni sessanta e settanta e molte sono le sue realizzazioni in Liguria e in Piemonte.
A Milano una delle sue opere più famose è il PAC, Padiglione di arte contemporanea, costruito tra il 1951 e il 1953 su un progetto del 1949. Chiuso nel 1973, per una profonda riqualificazione e riaperto nel 1979, fu distrutto da un attentato nel 1993 e successivamente restaurato, nel 1996, dal figlio di Gardella, Jacopo.
 É abbastanza particolare la convivenza tra il vecchio edificio della Stazione, e il nuovo fabbricato di Gardella: mentre il primo però gode dell’affaccio su una vera piazza, per quanto trafficata e luogo di interscambio di tram, autobus, metropolitana e ferrovia, la “nuova” stazione si affaccia su uno spazio destinato a parcheggio, decisamente irrisolto.
É abbastanza particolare la convivenza tra il vecchio edificio della Stazione, e il nuovo fabbricato di Gardella: mentre il primo però gode dell’affaccio su una vera piazza, per quanto trafficata e luogo di interscambio di tram, autobus, metropolitana e ferrovia, la “nuova” stazione si affaccia su uno spazio destinato a parcheggio, decisamente irrisolto.